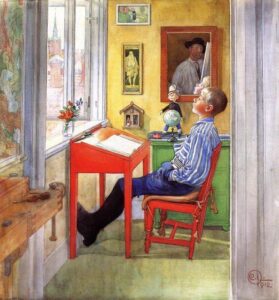Un libro è un seme. Nel cuore di un bambino trova il terreno giusto per germogliare.
Bentrovata e bentrovato,
comincio questo articolo dichiarando apertamente la mia posizione rispetto a un verbo che, ahimè, troppo spesso si insinua tra le parole, non solo dei “non addetti ai lavori”, ma soprattutto, di coloro che mangiano pane e letteratura (anche in ambito accademico). E premetto anche che questo articolo potrebbe risultare scomodo ai più.
Il verbo in questione è usare.
Dal Dizionario: utilizzare qualcosa per un fine, impiegare, adoperare. Fare uso di qualcosa o qualcuno, servirsi, valersi.
Molto frequentemente, il libro (e la Letteratura) è accostato a questo verbo: “uso il libro per… (trattare quella tematica, fare il laboratorio, trasmettere un messaggio/morale, iniziare un’attività, insegnare al bambino/a a…)”.
Sono reduce da una formazione universitaria (in qualità di discente) e, ad un certo punto, ho smesso di contare quante volte veniva pronunciato il verbo usare affiancato a parole come libro, albo illustrato, lettura, dai docenti coinvolti nella formazione e da molti insegnanti/educatori presenti.
Prima di esprimere il mio pensiero sull’argomento, ritengo sia doveroso fare una premessa per comprendere il motivo per cui, dal mio punto di vista, sia profondamente scorretto accostare ancora oggi la lettura e, ancor più la Letteratura, a questo verbo. La premessa in questione scava necessariamente nel passato e va a scomodare la Storia della Letteratura per l’Infanzia.
Certamente non intendo approfondire e sviscerare tutta l’evoluzione storica della Letteratura per l’infanzia (per questo ci sono numerosi volumi che svolgono egregiamente questo compito1), ma sintetizzo così la questione: la Letteratura per l’infanzia nasce come disciplina ambigua e la sua ambiguità è correlata alle sue origini, cioè all’essere stata una letteratura istruttiva, finalizzata ad insegnare più che a soddisfare i piaceri letterari; nasce cioè con un chiaro intento istruttivo-didascalico e moralistico, che si è protratto per tutto l’800 fino alla grande svolta della seconda metà degli anni ’80 del Novecento.

Cosa significa?
Come afferma Paul Hazard nel 19582: la Letteratura per l’infanzia nasce con un malinteso d’origine, come “un’aula scolastica ben mascherata“, perché in realtà non era una vera letteratura libera, ma attraverso le storie narrate e i personaggi inautentici, stereotipati e costruiti ah hoc (veri e propri congegni narrativi3), si volevano trasmettere in modo esplicito valori e comportamenti tipici di quel particolare periodo storico e contesto socio-culturale: come ti devi comportare, cosa devi fare, in quali valori credere, che tipo di cittadino essere, ecc.
Gradualmente, nel corso del ‘900, con alterne vicende, assistiamo però a una lenta trasformazione della Letteratura per l’infanzia in Italia, fino ad arrivare agli anni d’oro della grande svolta (1987 per Antonio Faeti, anno in cui alla Fiera Internazionale del Libro per Ragazzi di Bologna appare un’editoria innovata profondamente, da parte di tutte le case editrici).
E qui nasce un aspetto interessante, perché nel 1987 Anna Maria Bernardinis4 sostiene che la Letteratura per l’infanzia è stata pensata per il tempo libero e non in funzione scolastica. Inoltre, il libro di Letteratura non ha lo scopo di insegnare (valori o comportamenti) bensì è occasione di dialogo culturale libero e creativo, cioè la migliore Letteratura per l’infanzia non ha alcun intento istruttivo, se così fosse non sarebbe Letteratura e tanto meno Letteratura per l’infanzia.
La deriva istruttivo-didascalica a cui stiamo assistendo…
Bene, a questo punto penso sia lecito domandarsi: perché è necessario uno sguardo storico sulla Letteratura per l’Infanzia? Perché se io non conosco qualcosa di storico e non leggo alcuni passi storici, non posso comprendere né come si è sviluppata la Letteratura né come è cambiata nel corso dei secoli, ma soprattutto non posso snidare la quantità davvero industriale di editoria didascalica che oggi sta riproponendo alcuni modelli istruttivi della letteratura che ha dominato l’800 e buona parte del ‘900 e che sono assolutamente fuori tempo massimo e incongruenti.
Quando una mamma giovane entra in una libreria dicendo: «Vorrei un libro per insegnare al mio bambino a togliere il pannolino» ecco che siamo in piena metà dell’800. Non importa se vive nel 2025, la sua mente è nell’800.
Quando un insegnante/educatore, cerca un libro per… affrontare il tema della morte, del bullismo, della violenza, della disabilità, della gentilezza, ecc. siamo in piena metà dell’800. Non importa se lavora nel 2025, la sua mente è nell’800.
La maggior parte della produzione editoriale contemporanea è in fase di regresso e assistiamo, infatti, a un incremento spaventoso di libri istruttivi che vogliono usare le storie per insegnare questo e quest’altro ai bambini e ai ragazzi. Possibilmente così al libro si delega tutto (e il genitore non fa più niente): quasi che il libro sia diventato l’educatore, l’insegnante, il genitore. E via alla pubblicazione di libri e albi illustrati a tema, scritti intenzionalmente per affrontare una particolare tematica: l’albo per insegnare al bambino ad abbandonare il ciuccio, a fare la pipì nel vasino, ad accogliere l’arrivo del fratellino/sorellina, ad affrontare la morte, a superare il passaggio dalla Scuola dell’infanzia alla Scuola primaria, per non parlare poi di tutti i libri e gli albi illustrati sull’alfabetizzazione emotiva (che si prefiggono di insegnare le emozioni!). E ancora, l’abuso delle tematiche o dei filoni di moda che la cultura e la società portano a galla: abbiamo un’editoria che ci sta letteralmente inondando di opere sui bambini coraggiosi, le bambine ribelli, strane biografie, il ritorno agli stereotipi di genere, ecc.





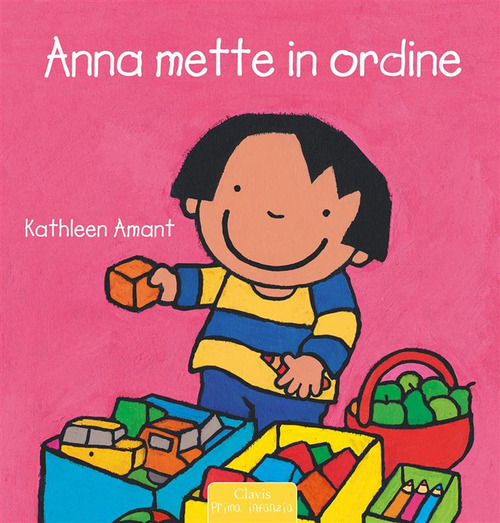







Immagini tratte liberamente dal Web.
Attenzione che l’istruttivismo e la strumentalizzazione della Letteratura non li troviamo soltanto nella produzione editoriale, ma anche nel come si lavora con i libri: noi possiamo avere tra le mani anche un albo/romanzo di qualità, per nulla didascalico, e nonostante questo farne comunque un uso istruttivo del libro. In che senso? Se io adulto (insegnante, educatore, promotore di lettura, bibliotecario) pongo al bambino/ragazzo domande di questo tipo: che cosa ci insegna questo libro? Che cosa ha voluto trasmettere l’autore/l’autrice? Quale messaggio possiamo trovare nel racconto? sto rendendo istruttivo il libro, sebbene questo non fosse il suo intento e non volesse, quindi, insegnare alcunché. Dunque, oltre a tradire l’autore, sto facendo un’operazione di mal-interpretazione e di forzatura nei confronti del libro e della storia che racconta.


Immagini tratte da Sussidiari di Scuola Primaria
Infine, una terza forma di istruttivismo e di strumentalizzazione a scopo didattico è quella che osserviamo sui siti degli editori, dove possiamo scaricare le schede di analisi del testo e gli apparati didattici. Le solite domande, anche a crocette, sulle opere di Letteratura: chi è il personaggio principale? In che luogo si sviluppa la storia? Oppure l’uso dell’opera di Letteratura per fare gli esercizi grammaticali (ad esempio per sottolineare i verbi o gli aggettivi, ecc.) o gli esercizi di punteggiatura. Una vergogna!



Usare = libro a tema = strumentalizzazione del libro e della Letteratura
Come scrive Alessia Napolitano nel suo Blog: “se le parole disegnano il nostro mondo e possono modificare il nostro pensiero, allora i due verbi disegnano un approccio al libro e alla lettura sostanzialmente diverso tra loro: il verbo usare è più legato ad una strumentalizzazione, il verbo leggere al piacere“.
Se il linguaggio veicola concetti, influenza e plasma la mente (Henri Brémond), credo che sia doveroso e più corretto da parte di chi educa sostituire il verbo usare con il verbo leggere e tutto assumerà un significato e una sfumatura diversi.
La Letteratura per l’infanzia è racconto di storie…
La Letteratura di qualità, quella vera, quella ispirata, non è nata per essere inserita in un progetto e quindi per essere adoperata, né per svolgere il programma scolastico, perché ogni libro, ogni opera andrebbe letta nella sua completezza per donare ai bambini e ai ragazzi tutto quello che ha dentro, per un dialogo culturale libero e creativo.

La buona Letteratura è una letteratura artistica (nell’illustrazione e nello stile), a misura di bambino/ragazzo, una letteratura che non insegna, una letteratura vera, una letteratura che racconta storie, che ha come obiettivo principale quello di arricchire umanamente e che da questo punto di vista è formativa, cioè mi aiuta a diventare il miglior me stesso possibile, a creare la mia identità, il mio progetto di vita; non mi modellizza, ma mi offre opportunità.
La migliore Letteratura contemporanea dimostra un primato della Letteratura sulla Pedagogia: ciò che conta è l’opera d’arte, le opere per bambini e ragazzi devono essere prima di tutto opere letterarie, tout court, in senso pieno e non opere costruite per insegnare. È una Letteratura ispirata, pluritematica, plurivaloriale, pluriemozionale, polisemica, autentica e libera.
Leggere = storie pluritematiche, plurivaloriali, pluriemozionali e polisemiche = dialogo culturale libero e creativo
Lasciamo che sia il libro semplicemente letto ad agire per le sue meravigliose e misteriose vie.
Allora, non mi resta che augurarti buone letture.
A presto…
- P. Boero, C. De Luca, La letteratura per l’infanzia. Edizioni Laterza, 1995 ↩︎
- P. Hazard, Uomini, ragazzi e libri.Letteratura infantile. Armando Editore, 1958 ↩︎
- S. Blezza Picherle, Letteratura per l’infanzia e l’adolescenza. Una narrativa per crescere e formarsi. QuiEdit, 2020 ↩︎
- A. M. Bernardinis, Nuovo dizionario di pedagogia. Edizioni Paoline, 1987 ↩︎